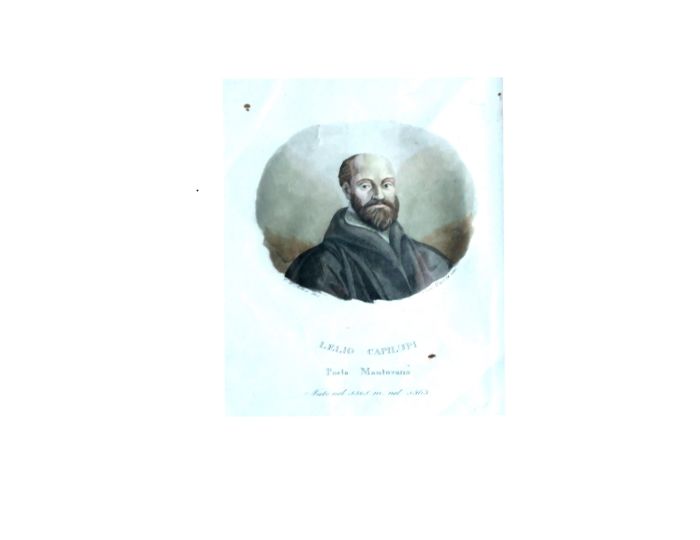
La famiglia Capilupi di Mantova.Vicende storiche di un nobile casato
Daniela Ferrari
Rotary Club Mantova, 17 gennaio 2017
Nel 2013 e nel 2014 Alberto, Carlo, Lelio, Flavia e Silvia Capilupi hanno affidato il loro archivio familiare, già conservato in parte nell’antica villa di Suzzara e in parte nelle residenze mantovane, in custodia all’Archivio di Stato di Mantova; il fondo documentario ha così potuto ritrovare una propria unitarietà ed è stato riordinato per essere messo a disposizione dei ricercatori.
L’acquisizione del materiale si è conclusa soltanto al termine dei miei lunghi anni di direzione di quell’istituto. Risalgono al 1996 i primi sopralluoghi effettuati presso gli eredi – che ringrazio per la cortesia con la quale mi hanno sempre accolta – per rispondere a studiosi italiani e stranieri che chiedevano di poter consultare o riprodurre qualche raro e prezioso manoscritto.
Si tratta di quasi duecento faldoni di documenti di grande interesse storico, datati dal XIV al XX secolo e di oltre un centinaio di volumi a stampa, appartenuti a una delle più illustri famiglie mantovane. Spicca su tutti un raro antecedente, un papiro del V secolo che vanta il primato di essere il più antico documento originale esistente in Lombardia, e uno dei più antichi del nostro Paese.
I Capilupi si distinguono soprattutto come letterati e come diplomatici al servizio dei Gonzaga, di vari papi e di altri signori dell’epoca: essi sono protagonisti e testimoni, dunque, dei principali avvenimenti accaduti in Italia e in Europa tra XIV e XVII secolo, e più particolarmente nel corso del Cinquecento. Il Dizionario Biografico degli Italiani ospita numerose voci, riferite a esponenti della famiglia, più o meno noti. Tali biografie, redatte negli anni Sessanta del Novecento, sono basate principalmente su fonti conservate in archivi pubblici, come l’Archivio Gonzaga, più che sui documenti del casato, all’epoca meno facilmente raggiungibili: pagine dense di storia, che ora potranno tuttavia essere in buona parte riscritte proprio grazie alla piena disponibilità dell’archivio familiare.
Bertolino (1340-1385 circa) è al servizio dei Gonzaga nelle vesti di cancelliere con importanti incarichi di politica estera a Bologna, Ferrara, Perugia, Padova, Venezia, e in particolare a Milano dove prepara diplomaticamente il matrimonio, celebrato nel 1381, tra Francesco Gonzaga e Agnese Visconti, occasione nella quale sovrintende alla preparazione di feste, cerimonie e cortei per accogliere la sposa a Mantova. Il favore dei Gonzaga gli consente di acquistare vari terreni nei dintorni di Mantova; egli possiede, inoltre, alcune case a Mantova, fra cui il palazzo in contrata San Leonardo (oggi via Concezione), di proprietà della sua famiglia sin dal 1270.
Benedetto (?-1526) è segretario particolare di Isabella d’Este e letterato in relazione con Pietro Bembo; a lui i Gonzaga donano cospicue terre nella “valle di Suzzara”, dove Alfonso Capilupi edifica nel 1567 la villa familiare che ancora conserva il nome Capilupi. Fine politico oltre che letterato, Benedetto è anche benemerito raccoglitore di codici che costituiscono il nucleo fondante della biblioteca Capilupi; una biblioteca di tutto rilievo, tanto da essere descritta dal padre gesuita Juan Andres, che in un catalogo stampato a Mantova nel 1797 recensisce ben 129 codici e manoscritti, 73 dei quali sono acquistati dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma nel 1932, mentre circa 30 sono stati ora individuati nell’archivio familiare pervenuto all’Archivio di Stato (primi fra tutti un codice di rime del Petrarca, in copia del Quattrocento, e il manoscritto originale di matematica e geometria di Bartolomeo Manfredi, celebre autore dell’orologio che ancora possiamo ammirare sulla torre di Piazza Erbe); oltre 20 risultano a tutt’oggi irreperiti.
Lelio (1497-1560), primogenito di Benedetto, insieme ai fratelli Alfonso, Camillo e Ippolito, si distingue nel campo letterario. Attratto a Roma nella sfera di relazioni del fratello Ippolito, Lelio è un cortigiano che nella Roma travagliata dai densi avvenimenti internazionali di metà Cinquecento, riesce a trovare lo spazio per un’attività personale spregiudicata, è definito una specie di Aretino in formato ridotto. Autore di versi di argomento politico, indirizzati a re e potenti di Europa, Lelio è anche studioso di Virgilio e si ritaglia una identità di letterato, oltre che di uomo politico.
Ippolito (1511-1580), fratello di Lelio, è compagno di studi del coetaneo Ercole Gonzaga – figlio di Isabella e di Francesco Gonzaga destinato alla carriera ecclesiastica -, condividendone l’educazione umanistica e l’insegnamento di Pietro Pomponazzo. E’ a Bologna nel 1530, al seguito del cardinale Ercole, che ben presto diventa suo protettore, per far parte della rappresentanza della corte mantovana alla incoronazione imperiale di Carlo V. Nel 1544 il cardinale Ercole, diventato reggente del ducato e nomina Ippolito agente mantovano presso il pontefice. A Roma Ippolito trova il terreno congeniale alle sue doti di prelato amante del fasto, estimatore delle arti e delle lettere, con un accentuato gusto dell’intrigo politico. Osservatore puntuale e smaliziato della vita romana, degli avvenimenti mondani della corte, della situazione politica internazionale, può vantare cordiali relazioni con numerosi letterati e artisti che affollano la corte pontificia: Paolo Giovio, Annibal Caro, Giovanni Della Casa, Michelangelo Buonarroti. Nel 1561 ottiene dal pontefice la nomina a nunzio presso la Repubblica di Venezia, dove frequenta artisti e letterati. Durante il primo soggiorno a Roma, come rappresentante del duca di Mantova, Ippolito acquista un antico palazzo in Campo Marzio – rinnovato e abbellito anche grazie ai suggerimenti di Michelangelo Buonarroti – ove raccoglie varie pregevoli opere d’arte, tra cui i ritratti tizianeschi di Giulia Gonzaga e del doge di Venezia Gerolamo Priuli; dopo la sua morte la raccolta viene trasportata a Mantova, andando ad arricchire quella già cospicua iniziata dal padre Benedetto.
Camillo (1531-1603), settimo di undici figli, destinato sin dall’infanzia alla carriera ecclesiastica, più che alla vita religiosa, si sente inclinato verso quella politica, nella quali i Capilupi vantano una brillante tradizione. Lo zio Ippolito lo introduce nella carriera diplomatica, chiamandolo a Roma dove può iniziare la sua attività di corrispondente della famiglia ducale per quasi mezzo secolo, offrendo una testimonianza pressoché insostituibile della vita politica romana, oltre che del costume cortigiano, come era nelle tradizioni della migliore diplomazia gonzaghesca. Nel 1585 ottiene da Sisto V la carica di protonotario apostolico, che costituisce il culmine della sua carriera curiale. Nel 1599 si ritira a Mantova, dove trascorre gli ultimi anni circondato dagli splendidi oggetti d’arte che egli e lo zio Ippolito avevano appassionatamente collezionato in tanti decenni di soggiorno romano: quadri del Titano, del Costa, di Giulio Romano, arazzi, argenterie e preziosi codici di Terenzio, di Virgilio e di Stazio.
Al seguito di Ippolito si trasferiscono tutti figli di Camillo I: il 29 marzo 1566 sono dichiarati cittadini romani i fratelli Alfonso, Camillo, Alessandro e Orazio, e questo è un segno di grande fortuna che comprova l’alta dignità raggiunta dal casato. Insieme, per adeguarsi al nuovo grado occupato dalla famiglia nell’Urbe, prima affittano e poi acquistano una casa in Campo di Marte, dove allestiscono una vera e propria cancelleria per il disbrigo degli affari diplomatici.
Il periodo di massimo splendore della famiglia è raggiunto tra la fine del Cinquecento e la fine del Seicento: è questo un secolo di indiscusso successo per tutti i membri della famiglia in ogni settore della vita pubblica e privata; i Capilupi nel Cinquecento possiedono oltre 1500 bm, circa 470 ettari; a metà Seicento le biolche mantovane sono oltre 1000. Essi organizzano, inoltre, un’area di controllo sugli stabili e sui terreni limitrofi al loro palazzo, con l’acquisizine del palazzo De Grado (situato nell’odierna piazza San Giovanni), per cui sul finire del secolo dispongono di una autentica cittadella in un susseguirsi di case, orti, stalle, botteghe e giardini introno ai due palazzi.
Negli anni Trenta del Seicento, Scipione – i cui fratelli erano morti nel 1624 e nel 1631 – si trova a essere a capo di una immensa fortuna che comprende tutte le proprietà del ramo iniziato da suo nonno Alfonso, dislocate a Fossato, a Curtatone, a Suzzara a Sermide e a Mantova con un’estensione fondiaria di oltre 1.800 biolche, pari a 566 ettari.
Scipione Capilupi rimane vedovo di Laura Cavriani e sposa in seconde nozze Vittoria Strozzi che porta in dote la ricchissima corte Bellacqua di Goito (quasi 200 biolche); Vittoria Strozzi muore, a sua volta, di peste insieme ai figlioletti e ad altri membri della famiglia, cosicché Scipione rimane l’unico superstite del suo ramo e nel 1632 sposa in terze nozze Caterina Facchini, vedova Di Bagno: è uno degli aristocratici più facoltosi del Mantovano.
Nel 1733 Carlo sposa la nobildonna ferrarese Bianca Sacrati, colta poetessa dell’Arcadia, che gli dà cinque figli. Tra cui Camillo V, l’erede maschio. Oltre a Camillo sopravvive soltanto Lavinia che sposa il marchese Gianfranco Gaspare Ballati Nerli nel 1763. In occasione di questa unione Carlo decide di rinnovare e abbellire la villa di Suzzara, ma il progetto globale di ristrutturazione non viene portato a termine causa il dissesto finanziario del marchese, come si rleva da un contratto del 3 giugno 1753.
Ha inizio un inesorabile processo di disinvestimento delle proprietà per recuperare risorse liquide da destinare alla copertura di debiti; nell’arco di poco più di un secolo vengono alienate circa 1370 biolche; secondo una tradizione orale interna alla famiglia pare che Carlo avesse perso al gioco un intero fondo in una notte, ma le radici del problema sono più profonde e sono da individuare nelle riforme attuate dal governo asdburgico, prima fra tutte il cosiddetto catasto teresiano realizzato per ottenere una più equa ripartizione delle imposte dirette, cui sono soggetti anche clero e nobiltà, da sempre classi privilegiate riguardo alle imposizioni tributarie.
Per atteggiamenti, comportamenti, valori, la famiglia Capilupi può essere considerata gruppo emblematico della classe nobiliare in alta Italia fra Quattro e Settecento: essi sono ambasciatori, segretari di stato, protonotari apostolici, vescovi, diplomatici, governatori, podestà e attraverso il loro patrimonio hanno contribuito e partecipato all’evoluzione politica ed economica dello stato mantovano.
Di altri esponenti della famiglia, meno conosciuti dei loro congiunti, o vissuti in anni più recenti molto ci sarebbe da aggiungere; cito, a titolo esemplificativo il marchese Alberto Capilupi ingegnere che si occupa di problemi idraulici e di opere di bonifica dell’agro mantovano-reggiano di Moglia; iscritto al partito dei moderati è consigliere comunale a Mantova e deputato al Parlamento del Regno nella XVII e XIX Legislatura; o ancora Alfonso Capilupi, agronomo e autore di studi su Bosco Fontana.
L’archivio Capilupi va così ad affiancare altri importanti archivi gentilizi conservati presso l’Archivio di Stato di Mantova, quali l’archivio Cavriani e l’archivio Arrigoni, l’archivio Castiglioni. La riconoscenza e la gratitudine agli eredi, che qui ribadisco, per l’alto senso civico che hanno dimostrato con la loro generosa azione, è stata testimoniata dalla affettuosa presenza del folto pubblico che ha partecipato alla presentazione dell’archivio, affiancata da una mostra documentaria, il 26 giugno 2015 nella sala mostre dell’Archivio di Stato di Mantova.

